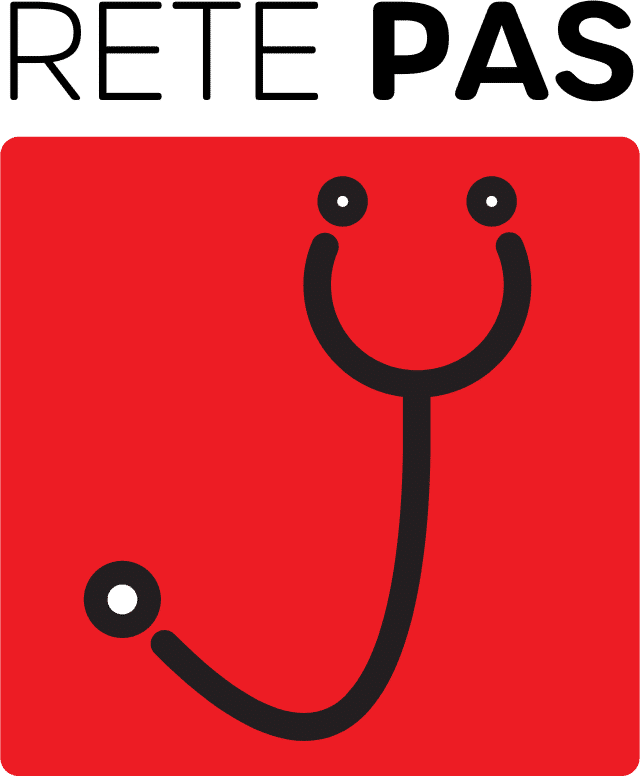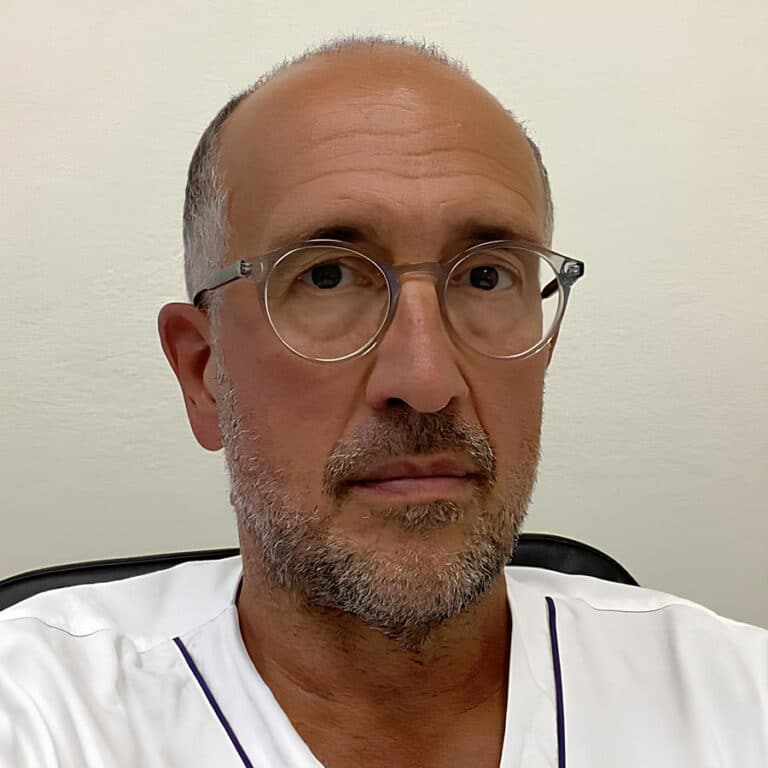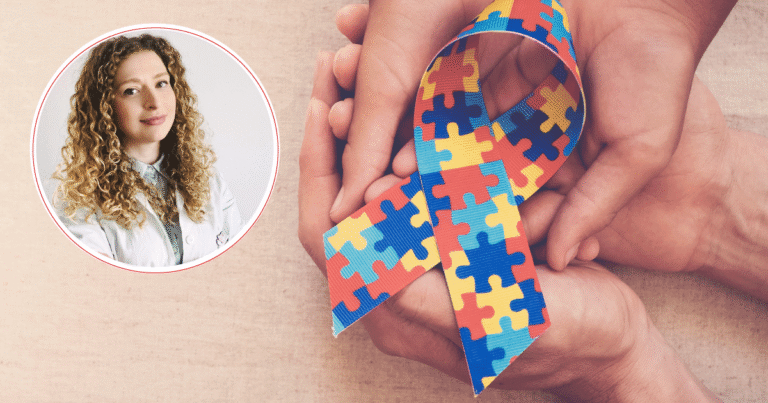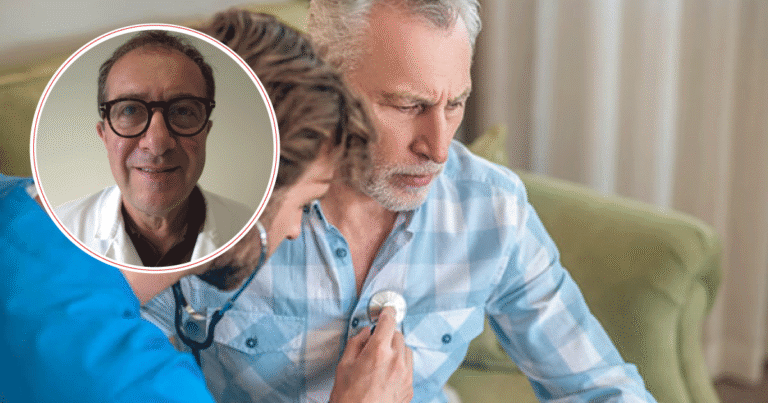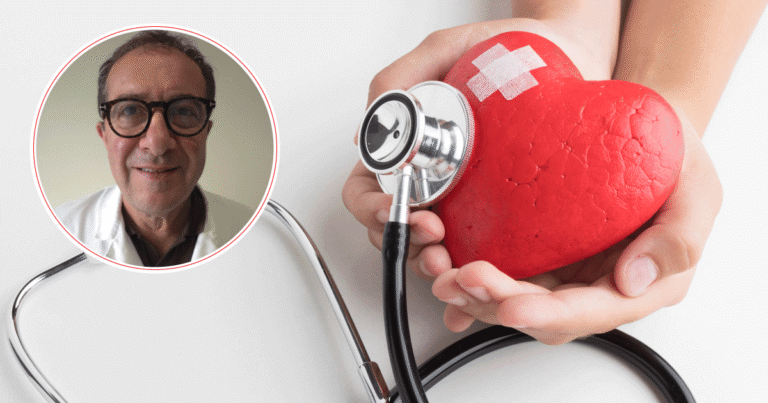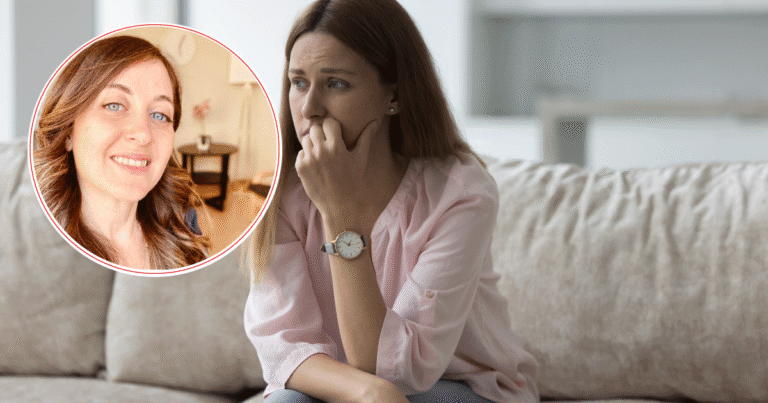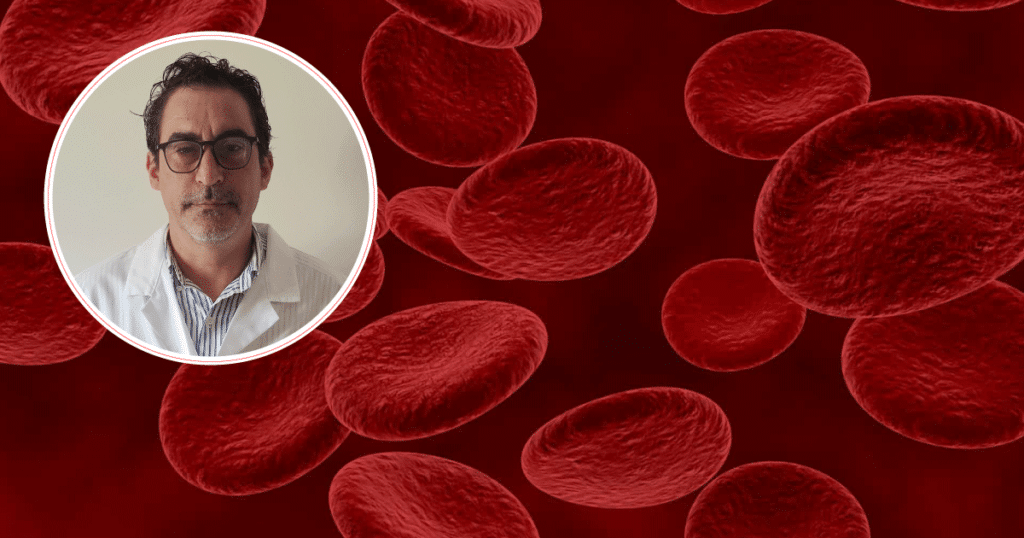Dottor Giacomo Gianfaldoni, ematologo di Rete PAS

Nel 1674 Antonie van Leeuwenhoek, ottico e naturalista olandese, utilizzando lenti da lui stesso fabbricate, fu il primo a osservare e descrivere i globuli rossi al microscopio. Questo evento segnò l’alba dell’ematologia, che da quel momento avrebbe cominciato a svilupparsi e progredire incessantemente. Una disciplina medica che continua a fare ricerca e ha raggiunto un livello avanzato nella comprensione della fisiologia del sangue, delle sue patologie, e nella capacità di fornire diagnosi e trattamenti sempre più accurati.
Che cos’è l’Ematologia?
È quella branca della Medicina che si occupa della fisiologia, della fisiopatologia e delle patologie del sistema emopoietico (midollo osseo) e di quello linfoide (linfonodi e milza). Il sistema emopoietico è responsabile della produzione delle cellule del sangue, mentre quello linfoide è preposto alla risposta immunitaria.
Quali sono le tecniche diagnostiche più comunemente utilizzate dagli ematologi per identificare le malattie del sangue?
Le tecniche diagnostiche utilizzate in Ematologia sono molto variabili e dipendono dalla patologia in esame. Ad un livello molto generale, possiamo distinguerle in esami di primo livello, che sono l’emocromo completo con formula leucocitaria, i reticolociti e i parametri biochimici (spesso sufficienti nell’inquadramento dell’anemia), e in esami di secondo livello, quali la tipizzazione immuno-fenotipica e le indagini genetico-molecolari, utilizzati prevalentemente nell’ambito di malattie onco-ematologiche. Inoltre, nell’ambito delle patologie a carico del sistema linfoide è necessario ricorrere ad indagini ecografiche e radiologiche come la TC (tomografia computerizzata) e PET (tomografia a emissione di positroni).
In aggiunta alla parte diagnostica, quanto sono importanti i sintomi descritti dal paziente?
Nonostante la crescente capacità diagnostica dovuta alle tecniche prima indicate, un’accurata anamnesi e un attento esame obiettivo sono di fondamentale importanza: non solo consentono al medico di orientarsi sulla eventuale patologia ematologica, evitando in talune circostanze un eccesso di esami, ma anche perché danno centralità al paziente.
In che misura la ricerca contribuisce a identificare e trattare le malattie ematologiche, soprattutto quelle più complesse?
Dopo un lungo periodo di stagnazione, negli ultimi anni assistiamo a una rapida evoluzione tanto nella parte diagnostica che in quella terapeutica. Stiamo entrando nell’ambito di una “medicina di precisione”, ovvero trattamenti mirati su bersagli molecolari o proteine di superficie che rendono la terapia più efficace e meno tossica.
Nel caso delle anemie, quali sono le cause, i sintomi ed eventualmente le terapie?
Le anemie possono essere grossolanamente distinte in due gruppi: le anemie iporigenerative, caratterizzate da una ridotta produzione midollare, e quelle da aumentata distruzione dei globuli rossi, definite emolitiche. Nel primo gruppo rientrano le anemie da deficit di ferro, acido folico e vitamina B12, l’insufficienza renale cronica, le anemie da disordine cronico (le più comuni nel paziente anziano), condizioni congenite quali le emoglobinopatie e patologie di tipo neoplastico quali le sindromi mielodisplastiche. Nel gruppo delle forme emolitiche, le più comuni sono quelle causate da auto-anticorpi diretti contro i globuli rossi, dunque malattie auto-immuni.
I sintomi e i segni dell’anemia dipendono dalla sua gravità (valore dell’emoglobina), dalla velocità con cui si è instaurata e dalla richiesta di ossigeno del paziente, nonché dalle sue comorbidità. I sintomi più comuni sono la dispnea a riposo e da sforzo, la facile affaticabilità, la tachicardia.
Per quanto concerne la terapia, questa dipende dalla causa dell’anemia. I trattamenti sono molto variabili (nelle anemie da disordine cronico non esiste un trattamento specifico). Nell’ambito delle anemie carenziali è di estrema importanza che l’ematologo non si limiti a somministrare la terapia, ma indaghi anche la causa del deficit. Per fare qualche esempio: in un paziente con deficit di ferro deve indagare eventuali sanguinamenti dell’apparato gastro-enterico oppure nel caso di deficit da vitamina B12 deve indagare eventuali difetti di assorbimento intestinale.
Quali patologie ematologiche possono essere trattate in una rete ambulatoriale?
L’ambulatorio ematologico ha il compito in primis di distinguere situazioni patologiche da quelle non patologiche. Sembra banale, ma molte alterazioni ematologiche non rappresentano condizioni patologiche. Ci sono patologie come le anemie, in particolare quelle carenziali, che possono essere diagnosticate e trattate a livello ambulatoriale, così come alcune sindromi mieloproliferative.
Nell’ambito delle patologie onco-ematologiche, alcune richiedono l’ospedale fin da subito, mentre altre non richiedono un trattamento immediato; in quest’ultimo caso è compito dell’ematologo monitorare la malattia e avviare il paziente all’ospedale quando comprende che è arrivato il momento di iniziare la terapia (l’esempio tipico è quello della leucemia linfatica cronica).
Quali sono le prospettive future per la ricerca e il trattamento delle malattie ematologiche e quali innovazioni possiamo aspettarci nei prossimi anni?
La crescente conoscenza della biologia delle malattie e lo sviluppo di tecnologie come l’ingegneria genetica porteranno a sviluppi straordinari. In particolare, per le malattie oncologiche assisteremo a un progressivo abbandono della chemioterapia convenzionale, la quale verrà sostituita da farmaci che colpiscono target molecolari e proteici, già disponibili nella pratica clinica. Alcuni esempi di questo radicale cambiamento sono gli inibitori del gene FLT3 per la leucemia mieloide acuta, gli inibitori del gene BCL-2 sia per la leucemia mieloide acuta che per alcune patologie linfoproliferative, e gli anticorpi monoclonali per i linfomi e il mieloma multiplo, che si sono dimostrati più efficaci e meno tossici rispetto ai trattamenti convenzionali. Inoltre, è in una fase iniziale di sviluppo la terapia genica per malattie ereditarie come la talassemia e l’emofilia.