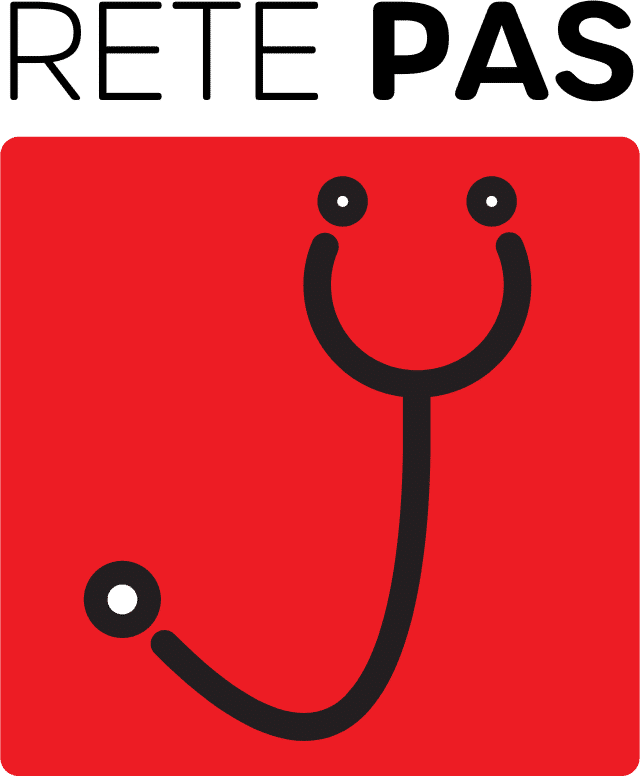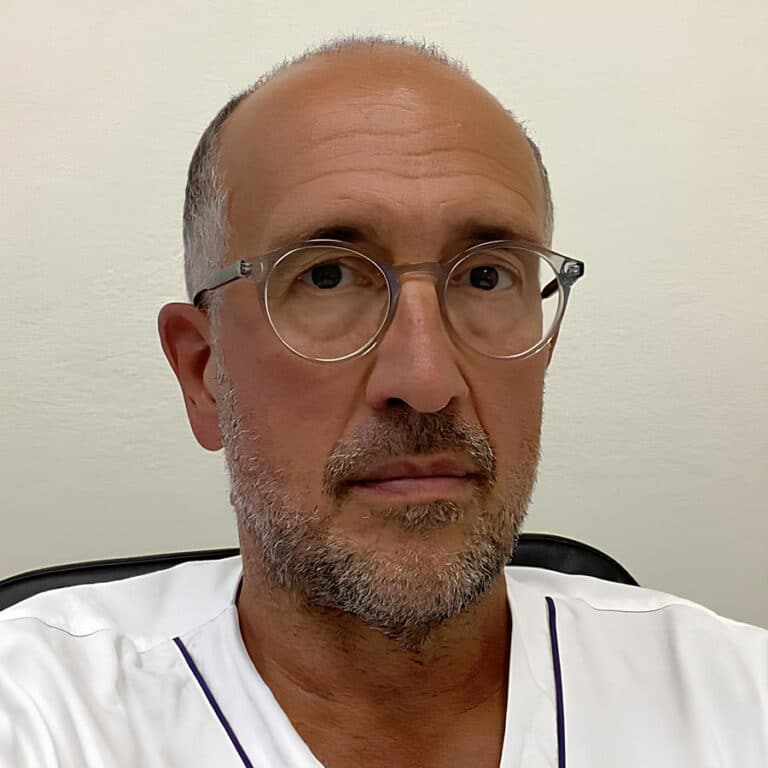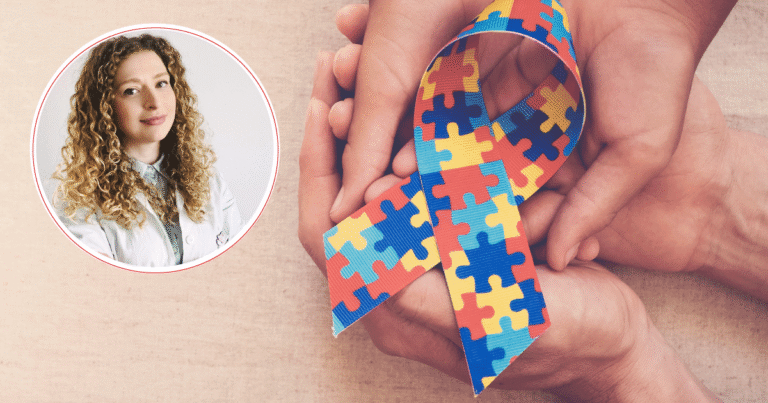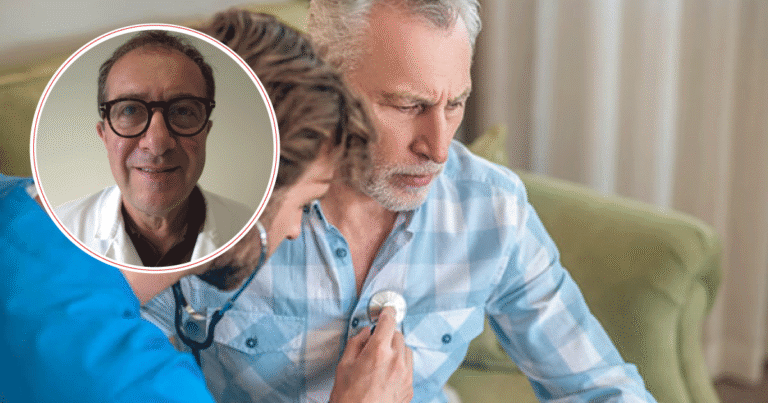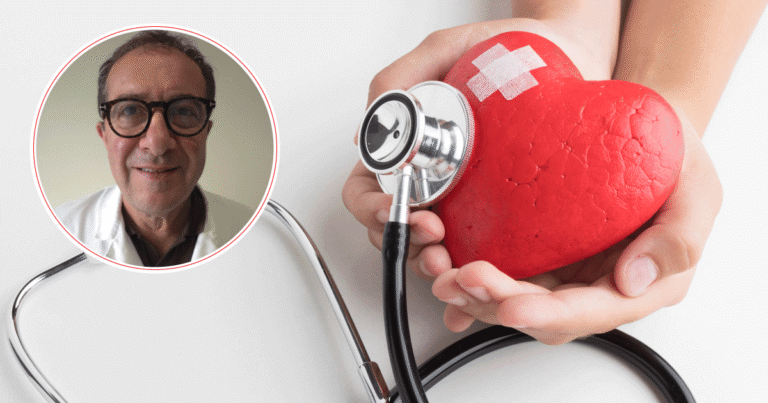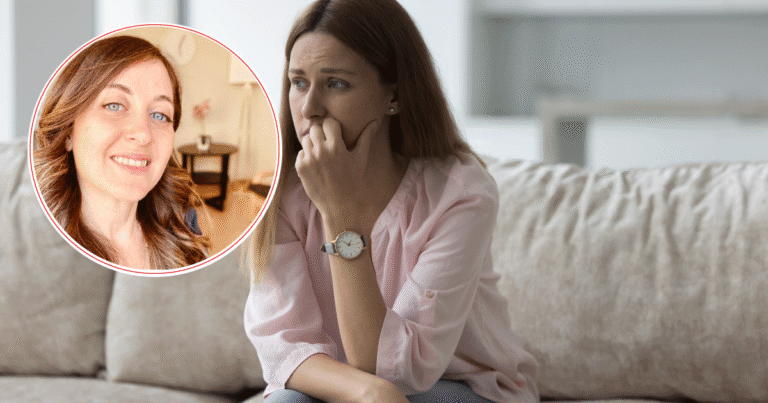Dottoressa Paola Allori, neuropsichiatra infantile di Rete PAS

Che cosa sono i disturbi specifici dell’apprendimento e perché vengono definiti «specifici»?
I disturbi specifici dell’apprendimento, DSA, sono disturbi specifici che riguardano settori dell’apprendimento, come la lettura, la scrittura e la matematica così come stati riconosciuti dalla L. n.170/2010. La normativa garantisce il diritto allo studio per chi ne è affetto, promuove la diagnosi precoce e percorsi didattici e riabilitativi mirati, per aiutare il percorso scolastico anche attraverso misure didattiche di supporto e promuovendo lo sviluppo delle potenzialità.
I disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali.
Secondo un report del Ministero dell’Istruzione e del Merito, la percentuale degli alunni con DSA sul totale dei frequentanti la scuola primaria e secondaria di I e II grado è pari al 5,7% per l’anno scolastico 2021/2022 e al 6% per quello 2022/2023.
Come vengono classificati i disturbi specifici dell’apprendimento? A quale età tendono a manifestarsi?
La classificazione classica comprende i seguenti disturbi: dislessia, disgrafia, disortografia, discalculia.
- Dislessia: disturbo specifico della lettura che si manifesta con una difficoltà nell’imparare a leggere, soprattutto in termini di decifrazione dei segni linguistici. Di conseguenza, la lettura risulta poco fluente e poco accurata, rendendo complicata la comprensione di un testo.
- Disgrafia: disturbo specifico della scrittura che incide sull’abilità grafo-motoria, manifestandosi con difficoltà nel realizzare una scrittura accurata, risultando di conseguenza irregolare, non lineare e poco leggibile.
- Disortografia: altro disturbo specifico della scrittura che riguarda la componente strettamente linguistica della scrittura stessa e consiste nella difficoltà di convertire correttamente il linguaggio orale in linguaggio scritto. Chi ne è affetto commette frequenti errori come omissioni, sostituzioni, inversioni di lettere o errori ortografici.
- Discalculia: si tratta di un disturbo specifico che riguarda l’area della matematica e si manifesta con problematiche nell’elaborazione dei numeri e nel calcolo aritmetico. Chi ne è affetto presenta difficoltà nella comprensione dei numeri, nella capacità di eseguire calcoli mentali e nell’applicare le regole matematiche di base (addizione, sottrazione, moltiplicazione, divisione).
Come già evidenziato, tali disturbi possono manifestarsi in via isolata oppure coesistere, cioè presentandosi in associazione tra loro, e magari con livelli di gravità diversi. Una difficoltà nella lettura, per esempio, si accompagna spesso a che a problemi nel calcolo e nella scrittura. I tempi di manifestazione variano in base all’entità del disturbo. In linea generale, il passaggio dal «sospetto» alla valutazione diagnostica dovrebbe avvenire tra la fine della seconda e l’inizio della terza classe della scuola primaria; purtroppo, questo passaggio non sempre avviene.
Quali sono le cause alla base di questi disturbi e che ruolo giocano i fattori ambientali?
Le cause specifiche di questi disturbi rimangono tuttora oggetto di studio. È ormai noto che non si tratta di una malattia, poiché non sono dovuti da un danno organico, ma da un diverso funzionamento del cervello, che richiede tempi più lunghi e carichi maggiori di attenzione. Si tratta caratteristica innata e non transitoria che presenta spesso una componente familiare, sebbene quest’ultima non sia un dato vincolante in senso. È importante analizzare e ricostruire con attenzione i tempi e le modalità dello sviluppo del linguaggio, considerato il ruolo imprescindibile che questo strumento riveste come prerequisito all’apprendimento. I fattori ambientali sfavorevoli – scarsa stimolazione, inadeguatezza delle cure, svantaggio socio-familiare – rappresentano un’aggravante ma non la causa.
Quali sono i possibili indicatori che fanno sospettare la presenza di un DSA?
La presenza di difficoltà nelle competenze comunicativo-linguistiche, nelle abilità motorie e prassiche, nonché nelle funzioni uditive e visuo-spaziali, in bambini senza patologie particolari, rappresenta indubbiamente un segnale di allarme, spesso riscontrabile in età prescolare, tanto più se la storia familiare è positiva per DSA.
In ogni caso, indipendentemente dalla natura specifica del disturbo, tali anomalie risultano facilmente identificabili sia dai genitori sia dagli insegnanti. Una volta avviata la scolarizzazione, per esempio, se è coinvolta l’area linguistica il bambino ometterà o sostituirà alcune lettere e avrà una punteggiatura o una sintassi inadeguata; se invece è coinvolta l’area prassica, la sua scrittura sarà difficilmente leggibile e poco lineare; infine, se è coinvolta l’area logico-matematica, il bambino avrà difficoltà nel contare, nel riconoscere i simboli matematici e i segni numerici ecc.
Quali sono i criteri e le procedure utilizzate per diagnosticare i DSA?
Il processo di valutazione si articola in una serie di test specifici per ciascun ambito di apprendimento, preceduti da una preliminare determinazione del livello intellettivo del bambino. Il criterio diagnostico si fonda sulla «discrepanza», ovvero il divario tra l’intelligenza generale e le competenze richieste da ciascun dominio specifico. Inoltre, per garantire una diagnosi accurata e integrata, è essenziale escludere la presenza di disturbi sensoriali, neurologici o della sfera emotiva.
A completamento del quadro diagnostico si aggiungono la valutazione logopedica e quella neuropsichiatrica, indispensabili per comprendere i bisogni del bambino in maniera globale e collocare l’eventuale disturbo all’interno del suo percorso evolutivo e del suo profilo di funzionamento psicologico. Al termine del percorso, il professionista sanitario – solitamente il neuropsichiatra infantile – redige un referto che documenta l’intera valutazione, mostrando i risultati dei test somministrati e, sulla base delle evidenze raccolte, elabora un giudizio clinico.
In che modo avviene «la presa in carico» dei DSA e quanto è importante in questo processo il coinvolgimento tra professionisti, famiglia e scuola?
La presa in carico si articola in diverse fasi: il bambino viene sottoposto alla valutazione; successivamente, strutture come la nostra, autorizzate dalla Regione in base al soddisfacimento di determinati criteri professionali, rilasciano una certificazione da consegnare alla scuola. È fondamentale che la presa in carico avvenga con tempestività, affinché il percorso riabilitativo sia il più efficace possibile. Non dobbiamo dimenticare che la riduzione del disturbo o dei disturbi specifici coinvolti deve essere finalizzata all’inserimento scolastico e sociale, ma con uno sguardo anche a quello lavorativo. Infine, è chiaro che il percorso riabilitativo richiede un rapporto di collaborazione e fiducia tra professionisti, famiglia e scuola, creando così un circolo virtuoso che mette al centro la persona, in questo caso il bambino.
Spesso, quando si parla di DSA, persiste il pregiudizio (errato) che essi siano legati a un deficit dell’intelligenza. Perché questa convinzione continua ad essere così diffusa?
Alcuni continuano a valutare l’intelligenza dei bambini in base alle loro prestazioni. Chi fa fatica ad automatizzare la lettura, per esempio, rischia di essere considerato «meno bravo» del compagno. È una disinformazione grave su cui dobbiamo continuare a lavorare, perché ha creato sofferenze del tutto ingiustificate a tanti bambini e alle loro famiglie. Come già detto all’inizio, la presenza di uno o più disturbi specifici non va ad intaccare il funzionamento intellettivo generale. Non a caso, il quoziente intellettivo (QI) è uguale o superiore alla media. Non si può fare diagnosi di DSA se non dopo aver valutato il QI, un bambino con diagnosi di DSA è per forza di cose un bambino con un’intelligenza normale, altrimenti non potrebbe avere quella diagnosi.
La scuola e l’insegnamento scolastico possono contribuire alla crescita educativa e alla valorizzazione dei talenti personali?
Credo che il compito primario della scuola sia «formare» attraverso l’insegnamento; il che vuol dire aiutare i ragazzi a strutturare una percezione di sé regolata e fiduciosa. Non dobbiamo sottolineare ciò che il bambino non sa fare, ma aiutarlo laddove è in difficoltà, valorizzare le sue risorse sane, e metterlo in grado di affrontare con tranquillità e consapevolezza il suo percorso di crescita. Per citare le parole del grande linguista americano Noam Chomsky: «Insegnare non dev’essere riempire una bottiglia d’acqua, piuttosto aiutare un fiore a crescere a modo suo».